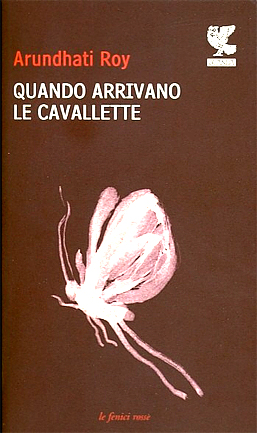|
||
|
Dove dovremmo andare dopo aver superato l'ultima frontiera? Dove volano gli uccelli oltre l'ultimo cielo? Dove dormono le piante dopo l'ultimo respiro?
MAHMUD DARWISH, La terra si sta richiudendo su di noi PREFAZIONE Il crepuscolo della democrazia Giacché ci stiamo ancora chiedendo se ci sia vita dopo la morte, possiamo mettere sul piatto un'altra domanda: c'è vita dopo la democrazia? E che tipo di vita sarà? Con «democrazia» non intendo un regime astratto e ideale cui aspirare. Mi riferisco al modello in funzione: la democrazia liberale occidentale con le sue varianti, prese così come sono. E allora, c'è vita dopo la democrazia? Tentare di rispondere a questa domanda spesso porta a paragonare i diversi sistemi di governo per giungere, in conclusione, a una difesa piccata e anche un po' aggressiva della democrazia. Ha i suoi difetti, diciamo di solito. Non è perfetta, ma è meglio di tutti gli altri sistemi a disposizione. Inevitabilmente, in sala c'è qualcuno che dice: «Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita, Somalia... preferireste così?» Se la democrazia sia una sorta di ideale cui devono tendere tutte le società «in via di sviluppo» è un'altra questione. (Io ritengo di sì. La fase iniziale, ancora piena di ideali, può essere davvero inebriante.) La domanda sulla vita dopo la democrazia è da porre a quelli tra noi che vivono già in democrazia, o in paesi che fingono di essere democratici. Non vuole suggerire che si debba ricadere in un modello precedente e ormai screditato di governo totalitario o autoritario. Quello che lascia intendere è che non è la nostra economia, ma l'ideale che ci siamo fatti della democrazia ad aver bisogno di un po' di adeguamenti strutturali. La vera questione, qui, è: che cosa ne abbiamo fatto della democrazia? In cosa l'abbiamo trasformata? Che succede una volta che la democrazia si è consumata? Quando è stata svuotata e privata di senso? Cosa succede quando ciascuna delle sue istituzioni si è fatta metastasi fino a trasformarsi in un'entità maligna e pericolosa? Cosa succede ora che democrazia e capitalismo si sono fusi in un unico organismo predatorio dall'immaginazione limitata e costretta, incentrata quasi esclusivamente sull'idea della massimizzazione dei profitti? È possibile invertire questo processo? Un'entità che è mutata può tornare a essere ciò che era prima? Ciò di cui abbiamo bisogno oggi, per la sopravvivenza del pianeta, è un progetto a lungo termine. Possono i governi democratici, la cui stessa sopravvivenza dipende da risultati immediati, dallo sfruttamento a breve scadenza, offrire questo progetto? Non potrebbe darsi che la democrazia, sacra risposta alle nostre speranze e preghiere a breve termine, baluardo delle nostre libertà individuali e nutrice dei nostri sogni più avidi, si riveli uno scacco matto per il genere umano? Non potrebbe darsi che la democrazia abbia tanto successo tra l'umanità moderna proprio perché ne rispecchia la più grande pecca: la miopia? La nostra incapacità di vivere nel presente, e al tempo stesso di guardare molto in là nel futuro, ci rende strani esseri «di mezzo», né bestie né profeti. La nostra intelligenza strabiliante sembra averci privato dell'istinto di sopravvivenza. Saccheggiamo la terra nella speranza di accumulare surplus materiali che compensino quella cosa profonda e indicibile che abbiamo perduto. Sarebbe presuntuoso affermare che i saggi di questa raccolta forniscano risposte anche a una sola di tali domande. Servono solo a dimostrare, in modo abbastanza dettagliato, che la luce del faro all'apparenza si fa sempre più fioca: non si può (forse) più contare sulla democrazia perché ci garantisca giustizia e stabilità come pensavamo potesse fare. Tutti i saggi sono stati scritti sotto forma di interventi pubblici urgenti in momenti critici della vita indiana: poco prima della data prevista per l'impiccagione di Mohammad Afzal (imputato nel caso dell'assalto al parlamento del 13 dicembre 2001), durante le rivolte di massa nel Kashmir (dell'estate del 2008) e dopo gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. Anche se quasi tutti sono stati pubblicati in India su giornali e riviste a grande diffusione, erano quasi sempre in contrasto con l'opinione «generale» prevalente. Spesso non erano solo risposte agli eventi, ma risposte ad altre risposte. Sebbene molti siano stati scritti con rabbia, in momenti in cui stare zitti era più difficile che dire qualcosa, i saggi hanno un filo comune. Non parlano di sfortunate anomalie o aberrazioni del processo democratico. Parlano di conseguenze e corollari della democrazia. Parlano di un incendio che inizia a divampare circolando nelle condotte dell'aria. Pagina 12 Oggi parole come «progresso» e «sviluppo» sono diventate termini intercambiabili con riforme economiche, deregulation e privatizzazioni. Due decenni di «progresso» di questo tipo hanno creato una vasta classe media in preda a una sbronza da ricchezza improvvisa, e una underclass molto, molto più estesa e disperata. Decine di milioni di persone sono state private della propria terra e costrette a sfollare a causa di enormi progetti infrastrutturali: dighe, miniere, zone economiche speciali, create nel nome della povera gente ma volte in realtà a ottemperare alle crescenti pretese della nuova aristocrazia. Oggi la lotta per la terra e l'accesso alle risorse è il cuore del dibattito sullo «sviluppo». L'anno scorso il ministro delle Finanze Panaliappan Chidambaram ha dichiarato che il suo progetto è l'urbanizzazione dell'85 per cento della popolazione indiana. Un cambiamento di questo genere richiederebbe un processo di manipolazione sociale di proporzioni impensabili, inducendo o costringendo circa 500 milioni di persone a emigrare dalle campagne in città. Certo, se mai fosse coronato da successo, libererebbe enormi porzioni di territorio insieme a tutte le risorse naturali del paese, che sarebbero così pronte per essere saccheggiate dalle multinazionali. Già ora foreste, montagne e sistemi idrici vengono devastati dalle razzie delle multinazionali, sostenute da uno stato alla deriva e in procinto di commettere ciò che si può solo definire come un «ecocidio». Interi ecosistemi vengono distrutti dalle miniere di bauxite e minerale ferroso che stanno desertificando sempre più l'Est dell'India. Sono in progetto centinaia di dighe di grandi dimensioni da realizzare sull'Himalaya, con conseguenze che non potranno che essere catastrofiche. Nelle pianure, gli argini costruiti lungo i fiumi, all'apparenza per irregimentare le alluvioni, hanno portato a un innalzamento dei letti fluviali che ha provocato alluvioni ancor maggiori, alla saturazione d'acqua nel terreno e alla salinizzazione dei campi coltivati, distruggendo così i mezzi di sostentamento di milioni di persone. Altrove, il passaggio da un'agricoltura sostenibile e a scopo alimentare a una intensiva e speculativa ha indebitato fino al collo i piccoli coltivatori. Nel nostro paese, secondo íl conteggio più aggiornato, si sono suicidati più di 180.000 contadini. Fame e denutrizione a livelli simili a quelli dell'Africa sub-sahariana si diffondono a macchia d'olio in tutto il subcontinente. È come se una società vetusta, che marciva sotto il peso del feudalesimo e del sistema delle caste, fosse stata messa in un'enorme centrifuga per la panna. Il macchinario ha strappato la rete delle vecchie disuguaglianze, risistemandone alcune, ma per la maggior parte finendo per rafforzarle. Ora la società è stata scremata: è rimasto un sottile strato di panna densa, e un mucchio d'acqua. La panna è quel mercato indiano di molti milioni di consumatori (di auto, cellulari, computer, biglietti d'auguri per San Valentino) che fa invidia agli uomini d'affari di tutto il mondo. L'acqua conta poco. La si può spargere in giro, conservarla in bacini artificiali, o alla fine prosciugarla. (Almeno così pensano loro, gli uomini in giacca e cravatta. Non si aspettavano la guerra civile scoppiata nel cuore dell'India: in Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand e Bengala occidentale.) Pagina 17 Nel 2002, solo tre anni dopo i test nucleari, il governo del Gujarat guidato dal BJP e dal primo ministro Narendra Modi ha orchestrato un pogrom programmato con cura contro i musulmani di quello stato. L'islamofobia creata dall'amministrazione Bush all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001 ha dato ancora maggior impulso ai nazionalisti indù. Il governo dello stato del Gujarat è rimasto in disparte mentre più di mille persone venivano massacrate. Le donne erano vittime di stupri collettivi e poi bruciate vive. Circa 150.000 persone vennero cacciate dalle loro case. Dopo il pogrom, Narendra Modi fu confermato al potere dal popolo del Gujarat, cosa che si è ripetuta cinque anni più tardi. Ora è al suo terzo mandato come primo ministro. Ho evitato volutamente di aggiornare o alterare il testo di questi saggi, perché mi è parso interessante vedere come una lettura ravvicinata della natura «sistemica» di quel che sta accadendo spesso contenga una premonizione degli eventi a venire. Invece di aggiornare il testo dei saggi precedenti, ho inserito nuove note. Un paragrafo di un mio saggio sul genocidio del Gujarat dice: Si celebrerà un anniversario, nel marzo prossimo, o per allora ci sarà qualcun altro da odiare, in ordine alfabetico: adivasi, buddhisti, cristiani, dalit, parsi, sikh? Quelli che portano i jeans o che parlano inglese, oppure quelli che hanno le labbra carnose e i capelli ricci? Non dovremo aspettare a lungo le risposte. Nel 1984 folle capeggiate dai leader del Partito del Congresso massacrarono migliaia di sikh per le strade di Delhi. Nel gennaio del 1999 delinquenti appartenenti al Bajrang Dal, una milizia indù, aggredirono il missionario australiano Graham Staines e í suoi due figli piccoli, bruciandoli vivi. Già nel dicembre del 2007 le aggressioni contro í cristiani da parte delle milizie indù avevano travalicato il livello dell'«incidente casuale». In diversi stati governati dal BJP – Gujarat, Karnataka, Orissa – i cristiani venivano aggrediti e le chiese saccheggiate. A Kandhamal, Orissa, almeno sedici dalit e adivasi cristiani vennero uccisi da dalit e adivasi «indù». (L'«induizzazione» di dalit e adivasi, volta a mettere gli uni contro gli altri oltre che contro musulmani e maoisti, è forse il principale progetto delle milizie indù al momento.) Decine di migliaia di cristiani oggi vivono nei campi profughi o si nascondono nelle foreste circostanti, temendo persino di uscire per andare a coltivare i campi. Nel dicembre del 2008 folle di vigilantes indù a Bangalore e Mangalore hanno cominciato ad aggredire le donne che indossano jeans e abiti occidentali. In occasione delle elezioni, i partiti sfruttano questi massacri per ottenere vantaggi politici. A volte ne godono, in altri casi se ne servono per accusarsi reciprocamente di essere i fautori degli eccidi. In nessun caso, però, un partito politico ha commesso l'errore di assicurarsi che i colpevoli vengano puniti e sia fatta giustizia. Anzi, nonostante i veementi scambi di accuse pubbliche, si danno manforte l'uno con l'altro per evitare ripercussioni concrete. Non ci si può aspettare altro che un teatrino politico, una messinscena. Alla fine, le stragi vengono assorbite dal labirintico sistema giudiziario indiano, e lì lasciate a fermentare prima di venire rispolverate come materiale propagandistico per le elezioni successive. Si potrebbe dire che sono diventate parte integrante del tessuto della democrazia indiana. Nel gennaio del 2009 il rapporto organico tra Unione e Progresso – o se si preferisce tra Fascismo e Libero Mercato – è stato sancito con un bacio durante una cerimonia pubblica. Gli amministratori delegati di due delle principali corporation indiane, Ratan Tata del gruppo Tata e Mukesh Ambani della Reliance Industries, nel discorso di accettazione del premio Gujarat Garima (Orgoglio del Gujarat), hanno esaltato la politica di sviluppo attuata da Narendra Modi, artefice del genocidio del Gujarat e da loro caldamente sostenuto come candidato alla carica di primo ministro. Pagina 22 Poi, ovviamente, c'è il Kashmir. La contesa che a sentire alcuni analisti politici ha le maggiori probabilità di far piombare il mondo in una guerra nucleare. La guerra nella valle del Kashmir dura ormai da quasi vent'anni, e ha mietuto più di 70.000 vittime. Oltre 100.000 uomini sono stati torturati, diverse migliaia sono «scomparsi», mentre le donne sono state vittime di stupri e a decine di migliaia sono rimaste vedove. Più di 500.000 soldati indiani pattugliano la valle del Kashmir, cosa che la rende la zona più militarizzata del mondo. (Gli Stati Uniti avevano circa 165.000 soldati in servizio effettivo in Iraq al culmine dell'occupazione.) Ora l'esercito indiano sostiene di avere, per la maggior parte, stroncato la resistenza dei militanti islamici del Kashmir. Forse è vero. Ma il dominio militare significa vittoria? Per decenni dopo la Spartizione ci fu un accigliato rifiuto di «integrarsi» nell'India e accettare quello che la maggior parte dei kashmiri considerava (e considera tuttora) la dominazione indiana. Fu la causa di una crescente tensione tra India e Pakistan che sfociò per due volte in una guerra aperta. Con il continuo aumento della presenza dell'esercito indiano in Kashmir e lo scemare della prospettiva di un referendum sotto l'egida dell'ONU, la rabbia popolare si trasformò in un movimento di resistenza. Preoccupato dalla crescente influenza dei leader antindiani, nel 1987 il governo centrale manipolò smaccatamente le elezioni del parlamento dello Stato kashmiro. Le manifestazioni di protesta vennero soffocate con la forza bruta dalle unità di sicurezza indiane. In parte ispirandosi all'Intifada palestinese, la gente del Kashmir scese per le strade. La rabbia finì per tramutarsi in lotta armata. Migliaia di giovani kashmiri varcarono le montagne per andare in Pakistan a farsi addestrare e armare per combattere l'esercito indiano, uno dei più numerosi e formidabili del mondo. Gli addestratori erano stati le vere «levatrici» della vittoriosa jihad americana contro l'Unione Sovietica. Avevano formato le migliaia di mujaheddin islamici reclutati in tutto il mondo musulmano per combattere in Afghanistan. I giovani kashmiri fecero ritorno nella valle, addestrati all'arte della guerriglia, equipaggiati con armi moderne e animati dal sogno della libertà. Con loro vennero guerriglieri «stranieri», pakistani, afgani o provenienti persino da luoghi lontani come il Sudan. Molti di loro erano veterani di molte battaglie che sognavano la nazione panislamica. Introdussero una lettura più aspra e puritana dell'Islam, più interessata alla punizione che alla fede (alcuni lo definiscono «Islam americano»), una versione dell'Islam in precedenza sconosciuta nella valle del Kashmir. I servizi segreti indiani e pakistani colsero in fretta questa differenza di posizioni e la fomentarono (come Israele ha fatto in Palestina e gli Stati Uniti in Iraq). Ciò contribuì a creare spaccature fratricide che polarizzarono le posizioni della popolazione e diedero un tono apertamente religioso a quella che in sostanza era iniziata come una lotta per la libertà e l'autodeterminazione. Tale combinazione di islamizzazione, nazionalismo kashmiro militante e manipolazione cinica e astuta da parte delle istituzioni indiane e pakistane portò a una sorta di esodo della minuscola minoranza indù del Kashmir. Più di ogni altro aspetto, fu questo a fornire al governo indiano, e ai media «collaborazionisti», gli elementi necessari a demonizzare la lotta per la libertà del Kashmir, dipingendola come una rivolta religiosa intentata dai fondamentalisti islamici contro una democrazia laica. Perciò – strano, no? – alcuni degli elementi dell'Islam radicale, che non rappresentano nel modo più assoluto l'opinione della maggioranza dei kashmiri, sono in realtà gli alleati migliori e più utili al governo indiano nella sua campagna propagandistica. Come può un governo che si professa democratico giustificare un'occupazione militare? Tenendo regolari elezioni, ovviamente. Dopo ogni tornata, il governo indiano dichiara di aver ottenuto dal popolo del Kashmir il mandato per continuare imperterrito nella sua azione. [...] In mezzo a tutto questo scenario, il Kashmir è destinato a diventare il tramite del caos che si sta creando in Afghanistan e Pakistan: in India questo caos potrà far presa sulla rabbia dei più giovani tra i centocinquanta milioni di musulmani maltrattati, umiliati ed emarginati. Pagina 28 La «guerra al terrore» ha creato un clima che ha permesso ai governi di tutto il mondo di far approvare una serie di leggi antiterrorismo per la sicurezza nazionale nelle quali la definizione di «terrorista» è così vaga, ampia e lasca da potersi applicare praticamente a chiunque. In vari paesi, nascoste dietro il nuovo linguaggio della «guerra al terrore», sono state ripresentate con rinnovato entusiasmo vecchie divisioni manichee. In Palestina, la popolazione dovrebbe scegliere tra Hamas e l'occupazione israeliana. In India, tra il nazionalismo indù e il terrorismo islamico, tra le razzie delle multinazionali e la guerriglia maoista. Nel Kashmir, tra l'occupazione militare e le cellule militanti islamiche. Nello Sri Lanka, tra uno spietato stato singalese e le sentenze di morte delle Tigri Tamil. I popoli non dovrebbero essere costretti a compiere nessuna di queste scelte. Eppure sono sempre meno coloro che hanno il lusso di poter dire: «Non stiamo né con voi, né con i 'terroristi'». Chi quel privilegio lo possiede ancora, e lo esercita, corre il rischio di neutralizzarsi con quello che può facilmente trasformarsi in un esercizio di pura compassione, o nelle pallide banalità dei discorsi sui diritti umani, in cui l'equidistanza morale toglie l'urgenza politica e concreta da queste battaglie che sono politiche, urgenti e molto concrete. Anche chi ripudia la violenza sa bene che non si può mettere sullo stesso piano la violenza di un esercito d'occupazione con quella di chi gli oppone resistenza, oppure la violenza dei diseredati con quella degli approfittatori, la violenza del capitalismo delle multinazionali con quella delle comunità che lo combattono. Mentre gli attacchi contro la gente comune da parte dei governi, degli eserciti invasori e delle rapaci multinazionali si fanno sempre più feroci, lo stesso vale per la resistenza. Man mano che la resistenza nonviolenta viene inglobata, corrotta o resa inefficace, comincia a venir sostituita dalla militanza e dalla lotta armata. In breve tempo, le persone nel nome delle quali vengono intraprese queste lotte stanno diventando ostaggi dei metodi disperati a cui alla fine i movimenti violenti fanno inevitabilmente ricorso. Anche se la propaganda sulla «guerra al terrore» vorrebbe farci fare di ogni erba un fascio, è ovvio che non tutte le lotte armate sono uguali. Alcune sono di massa e, almeno nominalmente, rivoluzionarie. Altre no. Alcune sono apertamente sessiste e decisamente retrograde. Nel complesso, però, non esiste qualcosa che si possa definire una lotta armata «gentile» o compassionevole. Ci sono sempre spargimenti di sangue. C'è sempre una gran puzza. Capita così a chi combatte. Pagina 59 La fattoria degli animali 2 Dove George Bush dice davvero quel che pensa AVVERTENZA In quest'epoca di copyright, proprietà intellettuale, pirateria e plagio, desidero ammettere subito che questa pièce è interamente frutto d'imitazione. Le idee vengono tutte dai discorsi pubblici e dalle azioni del celebre poeta, pacifista, figlio dei fiori, libero pensatore e attivista sociale George W. Bush. Gran parte del testo è basato su un suo recente discorso di fronte all'Asia Society di Washington. Tutto l'incasso della serata dovrebbe essere devoluto a lui. Esterno giorno. Purana Qila. Lo zoo di Delhi È primavera. Gli alberi di nim hanno messo le foglioline novelle. I kapok e i kachnar sono in piena fioritura. Il parcheggio è pieno di Mercedes a motore acceso, con l'aria condizionata in funzione. Annoiati autisti in divisa ascoltano le canzoni delle colonne sonore dei film in hindi dagli stereo di auto di lusso. All'interno dello zoo le gabbie degli animali sono state ripulite da poco e odorano di ammoniaca. Sulle sbarre sventolano bandierine americane e indiane. Agenti di sicurezza americani, armati di tutto punto, muscolosi e con gli occhiali da sole, sono piazzati sopra ogni gabbia. Controllano la folla e i recinti in cerca del minimo accenno di guai. Il pangolino sembra metterli particolarmente sul chi vive. George Bush è in piedi all'interno di una gabbia con i vetri antiproiettile e si rivolge a un simposio di ricchi industriali e parlamentari, con qualche stella del cinema sparsa qua e là. Hanno tutti un sacco di anelli alle dita e braccialetti di filo rosso scolorito intorno al polso. GEORGE BUSH: Salve, gente fortunata! Grazie di aver trovato il tempo tra i vostri mille impegni di venire ad ascoltare il presidente degli Stati Uniti. (L'hulock bercia. L'orango continua a spulciarsi senza neppure sollevare lo sguardo. Il leopardo nebuloso cammina avanti e indietro. Il lori lento ha l'aria sorpresa.) Oggi sono qui per parlare delle due grandi democrazie dell'Asia, che ho deciso di invitare entrambe nel mio harem. L'Indìa... e l'Afghanistan... scusate: Pakistan. Porca vacca, lo sapevo che c'era uno «stan» da qualche parte... Però l'Afghanistan ce l'ho già nel mio harem, quindi non posso invitarla. Eh eh! L'Indìa è una democrazia perché la gente ha votato un governo che mi obbedisce. Il Pakistan è una democrazia perché il generale Musharraf ha il mio voto dalla sua parte. E lo stesso dicasi per i fondamentalisti dell'Asia centrale e dell'Arabia Saudita. La Palestina non è una democrazia perché li la gente ha votato dei tizi che non mi piacciono. Ma la mia democrazia preferita è l'Indìa. Più di cinquecento anni fa, il famoso genocida e fondatore della nostra nazione, Cristoforo Colombo, si mise in viaggio per scoprire le Indìe e dimostrò che la terra è rotonda. Ora il mio amico Tom Friedman dice che il mondo è piatto. Sinceramente me ne frega poco di che forma è, basta che appartenga a me e ci possa giocare tutto il giorno. Come sapete, però, Cris Colombo scoprì l'America invece dell'Indìa. Per fortuna di indìani ce n'erano un bel po' anche là. E con l'aiuto di Dio li abbiamo fatti fuori tutti, tra i quaranta e i sessanta milioni... scusate ma non ricordo il dato ufficiale, il mio ufficio stampa rilascerà una dichiarazione scritta più tardi. Non stiamo lì a sottilizzare, comunque: cos'è un piccolo genocidio tra amici? La cosa buona è che adesso abbiamo il paese tutto per noi. Terra dei liberi, dimora degl'impavidi. Abbiamo armi nuculari, più di quante se ne possa immaginare. Potrei distruggere tutto il mondo in un minuto se sono di cattivo umore. Eh eh! Scherzo, scherzo. Non sono un tipo umorale. E poi... sono dalla vostra parte per ora. Cioè, sono dalla vostra parte ora. Non sono vostro nemico, no? Ho l'aria di un nemico? L'avete visto A letto con il nemico? Io sì, e poi ho detto a Laura, il film non è male ma chi fotte chi? Ah! Si guarda intorno con quell'aria trionfale e sprezzante che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare. Mi spiace che Laura non sia venuta. Sta posando con qualche orfano, dalle suore di Madre Taresa, per un servizio fotografico. Mi sono divertito molto a incontrare il vostro primo ministro, il tizio col turbante e quella vocina buffa. Sto cercando di convincerlo a mollare quel paio di bombe nuculari che voialtri tenete nell'armadietto, così ve le guardo io. Il vostro primo ministro è un brav'uomo... è andato a Oxford, vero? Comunque bravo lo stesso. E poi si mette quel turbante ridicolo e quando mi guardo intorno vedo gente di tutti i tipi vestita in modi buffissimi, e alcuni hanno perfino certe barbe che sembrano musulmani. La gente che vive nei paesi caldi ha un odore strano e non usa il diodorante. Il mio diodorante preferito si chiama Freedom, ha un buonissimo sapore di limone. Non credo che la gente vestita in modo buffo dovrebbe avere le armi nuculari. Perciò, quelle bombe che avete nell'armadio, ecco, datemele, ragazzi. Negli Stati Uniti non le teniamo mica nell'armadio, le bombe. Solo gli scheletri, ci teniamo. E i nostri scheletrucci preferiti hanno anche dei soprannomi. Si chiamano Pace, Democrazia e Libero Mercato. I nomi veri sono Missile Cruise, Bomba Daisy Cutter e Bomba Sfonda-Bunker. Anche la Bomba a Grappolo ci piace. Tra noi la chiamiamo Claire. È proprio carina e ai bambini piace giocarci, e poi gli scoppia in faccia e li mutila o li ammazza. Che figata. Ma non raccontate a mia madre che ho detto così. Se no mi fa lavare la bocca col sapone. Oggi sono qui perché l'Asia si sta trasformando molto in fretta, e io voglio partecipare a tutta questa spirale di violenza e di distruzione dell'ambiente. Sono cose per cui vado matto, come di sicuro vi avranno riferito lamentandosi quegli idioti di Kyoto. Credo che non sia rimasto in Indìa un solo fiume con l'acqua potabile e la falda acquifera si sta abbassando sempre di più. Però adesso potete bere la Coca, che è più buona e fa più figo. E poi vi stanno arrivando quei bei centri commerciali enormi in cui si può comprare tutto se si hanno i soldi. Mi emoziono se penso che la vita dei ricchi indìani sta migliorando in fretta e che gli stipendi dei dirigenti d'azienda indìani cominciano a essere al livello di quelli dei loro pari occidentali. Bellissimo. Negli Stati Uniti li sovvenzioniamo, i nostri dirigenti. Li viziamo come dei bambini perché li amiamo davvero. E adoriamo anche i nostri contadini multinazionalizzati. Gli diamo miliardi di dollari di sovvenzioni perché sono brava gente. Mica come i vostri contadini, poveri, macilenti e con tendenze suicide. I vostri contadini non le meritano, le sovvenzioni, perché non sono brava gente. Dovreste dargli il Prozac. Così le aziende farmaceutiche americane ci guadagnerebbero ancora di più. Come dicevo la settimana scorsa alla Asia Society, è bello sapere che i ricchi indìani comprano condizionatori, elettrodomestici da cucina e lavatrici prodotti da aziende americane come la General Electric, la Whirlpool e la Westinghouse. Gli indìani più giovani stanno cominciando ad apprezzare la Domino's Pizza e i nostri hamburger rivoltanti.. Notizia splendida, perché gli americani sono stufi di essere l'unico popolo al mondo con problemi di obesità e una cucina veramente disgustosa. Ma tutte le cose brutte hanno un apsetto positivo. L'apsetto positivo... (Un assistente si china a sussurrargli «Aspetto, signor presidente».) E io cosa ho detto, Henry? L'aspetto positivo della nostra cucina orrenda è che rafforza la nostra decisione e il nostro impegno nella guerra contro i musulmani... scusate, contro i terroristi. Io adoro i musulmani. Quelli buoni, cioè, quelli che non sono terroristi ma lavorano nei call center. Il mio amico Tom Friedman mi dice che i musulmani dell'Indìa sono gente a postissimo. Per battere i terroristi i nostri servizi segreti vi spiano in continuazione. Non avete idea di quante cose sappiamo su di voi. Abbiamo telecamere di sorveglianza e sistemi wireless, e software che abbiamo infilato nei vostri computer per controllarvi in continuazione. Sappiamo dove andate, cosa comprate e con chi andate a letto. Io i terroristi li odio, perché pensano di aver diritto anche loro di ammazzare delle persone. Ma quand'ero piccolo, mia madre e mia nonna... si dice naani in hindi, vero? Mia madre e la mia naani mi dicevano che l'unica persona che ha il diritto di ammazzare le persone, bombardare i paesi e usare le armi chimiche e le armi nuculari è il presidente degli Stati Uniti. E indovinate un po' chi è? Comincia a lanciare grida di giubilo e fischi e spaventa tutti gli animali. Lo zoo si riempie di versi allarmati. Sono felice di essere qui perché adoro gli animali. Mi piace cacciarli, soprattutto quando sono in gabbia e non possono mordermi. Una volta, da piccolo, mi ha punto un'ape e mi sono messo a piangere. E poi mi piace combattere contro i paesi quando sono stati ridotti alla fame e costretti al disarmo. Sapete tutti come siamo stati furbi in Airaq. Le bombe le adoro, perché non devi star lì a guardare chi hai ucciso, ed è una cosa che va benissimo per i vigliacchi come me. Ma non dovete preoccuparvi, non sono qui per bombardarvi o ridurvi alla fame... perché tanto voi indiani siete già morti di fame. Ah ah! Si guarda intorno con aria tronfia e fa una faccia contrita quando si accorge di aver commesso un passo falso. Ops... ecco, questo è quello che mia nonna chiamerebbe uno sfondone! Mi dispiace. Il motivo per cui sono qui è che mi piacciono gli indiani ricchi. E il motivo per cui mi piacciono gli indiani ricchi è che sono ubbidienti e intelligenti e questa è un'accoppiata piuttosto rara. Negli Stati Uniti li consideriamo gli immigrati perfetti. Mi piacciono gli indiani ricchi, ubbidienti e intelligenti perché forniscono consulenze aggiuntive per risolvere i problemi e dare ai dirigenti americani informazioni cruciali sui bisogni dei consumatori nazionali e stranieri. L'Indìa è un mercato importante per i prodotti americani. Un miliardo di persone da sfruttare. La cosa migliore è che il governo indiano ci lascia prendere la roba che appartiene all'Indìa – carbone, bauxite, minerali, perfino l'acqua e l'elettricità – e ci permette di rivendergliela incassando profitti enormi. Che divertimento. Lo adoro, il governo indiano. Purtroppo, di quel miliardo di persone la maggior parte è povera. Io i poveri li odio, perché non hanno i soldi per comprarsi niente. Vorrei tanto che sparissero. Sono stato felice di sentire che decine di migliaia di contadini indiani si stanno sucidando. Negli Stati Uniti lo chiameremmo un comportamento irresponsabile e autodistruttivo. Ma se potessimo accelerarlo solo un po', incanalarlo su una via più diretta, potremmo cambiare le cose velocemente. Però i poveri sono bravi come donne di servizio e lavoratori di fatica, perciò dobbiamo tenerceli. Speriamo che presto le multinazionali americane diventino proprietarie di tutti i semi, le piante, la biodiversità e le infrastutture essenziali dell'Indìa, e anche delle nuove idee indìane. Come dicevo, gli indìani sono piuttosto svegli e ogni tanto hanno buone idee. Non possiamo permetterci di lasciargliele. Non possiamo permettere ai contadini di possedere i semi. Tutti devono chiedere a noi per tutto. Mi piace tanto quando tutti devono chiedermi il permesso. Dick dice che la parola chiave è controllo. Una delle multinazionali americane di cui andiamo più fieri è stata fondata da Bill Gates. Lui in Indìa ci viene spesso. È un uomo meraviglioso e generoso. Dà al governo indìano milioni di dollari per combattere l'Hiv e l'Aids. Non mi piacciono quelli che hanno l'Hiv e l'Aids perché sono quasi tutti neri e omo. Mi piacciono le aziende che fanno le medicine contro l'Aids che nessuno può permettersi. È uno humour nero e pungente che apprezzo molto. Ma parlavo di Bill. In cambio dei milioni di Bill Gates, il governo indìano compra da lui centinaia di milioni di dollari di tecnologia informatica. È così ricco che ho paura che scoppi. Quando gli sto vicino metto sempre addosso un grembiule. Ma sono abbastanza ricco anch'io. E anche i miei amici, e gli amici degli amici, e gli amici degli amici degli amici. Soprattutto Dick Cheney. Li facciamo insieme, io e lui, i nostri affari sporchi. Petrolio, armi, e via dicendo. Peccato per com'è finita la Enron. Ma è stato bello finché è durato. Dick lo adoro soprattutto perché mi dice cosa dire alle conferenze stampa. Mi manca. Ma non andrò mai a caccia con lui. Potrebbe spararmi con il suo fucile detenuto illegalmente, e non so proprio cosa farò quando sarò morto. Non vedo l'ora di bombardare l'Airan. Abbiamo delle nuove armi che voglio sperimentare. Ci sarà da divertirsi, credo. Spero che l'Indìa ci mandi un po' di soldati ad aiutarci. Siete così in tanti che non cambierà molto se ne perdete un po'. E comunque vi suicidate a carrettate, ed è una cosa illegale. E allora perché non farvi ammazzare legalmente in Airan o in Airaq? Potremmo creare delle green card postume. Le facciamo plastificare. Però la plastificazione sarebbe a carico dei defunti. Pensateci. Grazie dell'attenzione. Ora devo scappare. Jai Hind. Viva l'India. Ci si vede. 28 febbraio 2006 Pagina 85 Quando arrivano le cavallette Genocidio, negazione e tripudio Non ho mai conosciuto di persona Hrant Dink, purtroppo, e questa lacuna mi rimarrà per sempre. Da quel che so di lui e di ciò che scriveva, diceva e faceva, del modo in cui viveva la sua vita, so che se mi fossi trovata qui a Istanbul un anno fa sarei stata tra le centomila persone che hanno accompagnato la sua bara in silenzio assoluto per le vie gelate della città, reggendo cartelli con la scritta «Siamo tutti armeni» o «Siamo tutti Hrant Dink». Forse io ne avrei portato uno con scritto «Un milione e mezzo + uno». Mi chiedo che pensieri mi sarebbero passati per la testa camminando accanto alla bara di Hrant Dink. Forse avrei risentito la voce di Araxie Barsamian, madre del mio amico David Barsamian, mentre raccontava la storia sua e della sua famiglia. Nel 1915 Araxie aveva dieci anni. Si ricordava degli sciami di cavallette che avevano invaso il suo villaggio, Dubne, a nord della storica città di Dikranagert, l'odierna Diyarbakir. Gli anziani del villaggio ne erano allarmati, raccontava Araxie, perché se lo sentivano nelle ossa: le cavallette erano cattivo segno. E avevano ragione. La fine sarebbe giunta di lì a pochi mesi, con il grano pronto per il raccolto nei campi. «Quando ce ne andammo, la mia famiglia contava venticinque persone in tutto» diceva Araxie Barsamian. «Si presero tutti gli uomini. Chiesero a mio padre: 'Dove tieni le munizioni?' E lui rispose: 'Le ho vendute'. Allora gli dissero: 'Va' a riprenderle'. Mio padre andò a riprendersele, nella città curda, e lì lo riempirono di botte e gli portarono via anche i vestiti. Quando tornò a casa – me l'aveva raccontato mia madre – quando tornò, nudo come un verme, finì in prigione. Gli tagliarono le braccia... e morì in prigione. Poi portarono tutti gli uomini nei campi, legarono loro le mani e spararono. Li uccisero tutti.» Araxie, sua madre e i tre fratelli minori furono deportati. Morirono tutti tranne lei. L'unica sopravvissuta. Questa è una singola testimonianza di un avvenimento storico negato dal governo turco e anche da molti cittadini turchi. Ma io non sono venuta qui per giocare all'intellettuale globalizzata, che viene a farvi la predica, o a spezzare il silenzio che in questo paese circonda la memoria (o l'oblio) degli eventi accaduti in Anatolia nel 1915. Ci aveva provato Hrant Dink, a farlo, e l'ha pagato con la vita. Pagina 89 Nel 2002 lo stato del Gujarat fu teatro di un genocidio contro la comunità musulmana. Uso questo termine, «genocidio», a ragion veduta, secondo la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione dell'ONU per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Il genocidio del Gujarat ebbe inizio come punizione collettiva per un crimine irrisolto, l'incendio di una carrozza ferroviaria in cui 53 pellegrini indù morirono carbonizzati. L'orgia della vendetta, pianificata nel dettaglio, vide 2000 musulmani massacrati alla luce del giorno da squadracce di assassini armati, organizzati dalle milizie fasciste e sostenuti dal governo del Gujarat e dall'amministrazione in carica. Donne musulmane furono vittime di stupri collettivi e bruciate vive. Negozi e aziende musulmani, luoghi di culto e moschee vennero sistematicamente distrutti; 150.000 persone furono cacciate dalle loro case. Ancor oggi molte di loro vivono in ghetti – alcuni dei quali costruiti sopra discariche di rifiuti – senza acqua corrente, fognature, illuminazione stradale, assistenza medica. Vivono come cittadini di seconda classe, boicottati sul piano sociale ed economico. Nel frattempo gli assassini, appartenenti alla polizia o semplici cittadini, sono stati encomiati, ricompensati e promossi. Questo stato delle cose è ormai considerato normale e nel 2004, a sancirne la «normalità», sia Ratan Tata che Mukesh Ambani, i principali industriali indiani, hanno dichiarato pubblicamente che il Gujarat è una destinazione ideale per gli investimenti finanziari. L'indignazione iniziale della stampa nazionale si è placata. Nel Gujarat il genocidio è stato impudentemente celebrato come l'epitome dell'orgoglio gujarati, dell'«identità indù» e persino dell'«indianità». Questa miscela velenosa è stata usata due volte di fila per vincere le elezioni dello stato, grazie a campagne che hanno sfruttato abilmente il linguaggio e i meccanismi della modernità e della democrazia. Il capofila, Narendra Modi, diventato una specie di eroe popolare, è stato chiamato dal BJP a fare campagna elettorale per íl partito anche in altri stati dell'India. In quanto a genocidi, quello del Gujarat non è comparabile a quelli di Congo, Ruanda e Bosnia, in cui le vittime si contano a milioni; e non è neppure il primo, in India. (Nel 1984, per esempio, 3000 sikh furono massacrati per le vie di Delhi in un clima d'impunità simile, per mano di assassini controllati dal Partito del Congresso.) Ma il genocidio del Gujarat fa parte di una prospettiva più ampia, elaborata e sistematica. Ci dice che il grano è quasi maturo e le cavallette sono sciamate anche sul suolo indiano. È un antico vizio dell'uomo, il genocidio. Ha avuto un ruolo non secondario nella marcia verso la civiltà. La distruzione di Cartagine al termine della terza guerra punica, nel 149 a.C., viene considerata uno dei primi genocidi registrati dagli storici. Il termine «genocidio», però, fu coniato solo nel 1943 da Raphael Lemkin, e adottato dalle Nazioni Unite nel 1948 in seguito allo sterminio perpetrato dai nazisti. L'articolo 2 della Convenzione dell'ONU per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio lo definisce così: Uno dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: (a) uccidere membri del gruppo; (b) provocare loro gravi danni fisici o mentali; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne l'annientamento fisico in tutto o in parte; (d) imporre misure volte alla prevenzione delle nascite all'interno del gruppo; (e) trasferire con la forza i figli dei membri del gruppo a un altro gruppo. Dato che la definizione non fa cenno alla persecuzione dei dissidenti politici, reali o immaginari, non include alcuni dei più grandi stermini di massa della storia. Per quanto mi riguarda, ritengo più adatta la definizione data da Frank Chalk e Kurt Jonassohn, autori di The History and Sociology of Genocide. Il genocidio, sostengono i due studiosi, «è una forma di massacro di massa unilaterale in cui lo stato o un'altra autorità intende distruggere un gruppo. Il gruppo è definito, così come i suoi membri, dall'aggressore.» Questa definizione di genocidio comprenderebbe, per esempio, anche i crimini gravissimi commessi da Suharto in Indonesia, Pol Pot in Cambogia, Stalin in Unione Sovietica e Mao in Cina. Tutto sommato la parola «sterminio», che può evocare le disinfestazioni di insetti o animali nocivi, è forse la più onesta e la più adatta. Quando un gruppo di aggressori si propone di perpetrare una serie di massacri sfrenati, per riuscirci deve per prima cosa recidere ogni legame umano con le proprie vittime. Le deve considerare esseri subumani, parassiti, la cui eliminazione renderà un servizio alla società. Ecco, per esempio, un resoconto datato 1636 del massacro degli indiani Pequot del Connecticut per mano dei puritani inglesi guidati da John Mason: Chi scampò al fuoco fu passato a fil di spada. Alcuni furono fatti a pezzi, altri infilzati con lo stocco, così da finirli seduta stante, e in pochissimi riuscirono a fuggire. Si calcolò che ne avessero eliminati circa 400 a questo modo. Era una scena terribile vederli bruciare nel fuoco, le cui fiamme venivano spente dai rivoli di sangue, mentre tutto era avvolto da un lezzo acre e tremendo, ma pur di ottenere la vittoria parve un sacrificio dolcissimo... Ed ecco, a distanza di circa quattro secoli, le parole di Babu Bajrangi, uno degli uomini cardine nel genocidio del Gujarat, registrato pochi mesi fa da una telecamera nascosta durante un reportage sotto copertura del settimanale «Tehelka»: «Non abbiamo risparmiato un solo negozio musulmano, abbiamo dato fuoco a tutto... sfasciato, bruciato, incendiato... preferivamo dargli fuoco perché quei bastardi rifiutano la cremazione, la temono...» Non c'è bisogno che io dica che Babu Bajrangi godeva della benedizione di Narendra Modi, della protezione della polizia e dell'amore del suo popolo. Ancora oggi continua a lavorare e a vivere bene e a piede libero nel Gujarat. L'unico delitto di cui non lo si può accusare è il negazionismo. Negare i genocidi è una notevole variazione sul vecchio tema apertamente razzista del trionfalismo sanguinario. È nato probabilmente come risposta a una forma di moralità doppia e lacunosa nata nell'Ottocento, quando l'Europa iniziava a sviluppare forme nuove, seppur limitate, di democrazia e di riconoscimento dei diritti del cittadino a casa propria, e al tempo stesso sterminava milioni di persone nelle colonie. Tutt'a un tratto paesi e governi cominciarono a negare o a cercare di nascondere i genocidi da loro commessi. «Il negazionismo significa dire, in effetti, che gli assassini non hanno ucciso nessuno» sottolinea il professor Robert Jay Lifton, autore di Hiroshima in America: A Half Century of Denial, «che le vittime non sono state ammazzate. La conseguenza diretta di questa negazione è l'invito a nuovi genocidi.» Certo, al giorno d'oggi, quando la politica del genocidio incontra il libero mercato, l'ammissione ufficiale o la negazione di olocausti e genocidi è un business internazionale. Solo di rado ha a che fare con eventi storici o prove giuridicamente valide. E di certo in questo quadro la moralità c'entra poco. È un aggressivo processo di contrattazione ai massimi livelli, legato più al WTO che all'ONU. La valuta corrente è la geopolitica, il mercato ondivago delle risorse naturali, quegli oggetti curiosi chiamati futures e la cara, vecchia e semplice idea della potenza economica e militare. In altri termini, i genocidi spesso vengono negati per le stesse ragioni per cui vengono perseguiti. È determinismo economico marinato in salsa di discriminazione razziale/etnica/religiosa/nazionalista. In parole povere, la crescita o la diminuzione del prezzo di un barile di greggio (o di una tonnellata di uranio), l'autorizzazione alla costruzione di una base militare o l'apertura agli investimenti dell'economia di un paese possono rivelarsi fattori decisivi nel momento in cui un governo deve giudicare se un genocidio abbia o non abbia avuto luogo. Oppure se un genocidio avverrà o no. E quando avviene, se ne verrà data notizia o no, e nel caso, che taglio avranno i reportage giornalistici. Per esempio, la morte di due milioni di persone in Congo è passata quasi completamente sotto silenzio. Perché? E la morte di un milione di iracheni nel periodo delle sanzioni, prima dell'invasione statunitense, era da considerare genocidio (come l'ha definito Denis Halliday, coordinatore degli aiuti umanitari dell'ONU in Iraq)? Oppure «ne valeva la pena», come ha sostenuto Madeleine Albright, ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU? Dipende da chi stabilisce le regole: Bill Clinton? O una madre irachena che ha perso suo figlio? Dato che gli Stati Uniti sono il paese più ricco e potente del mondo, si sono arrogati il privilegio di essere i primi «negatori» di genocidi del pianeta. Continuano a festeggiare il Columbus Day, il giorno dello sbarco di Colombo nelle Americhe, punto d'inizio di una strage che spazzò via milioni di nativi americani, circa il 90 per cento della popolazione originaria. Lord Jeffrey Amherst, l'ideatore della brillante trovata di distribuire coperte infette dal vaiolo agli indiani, dà il suo nome a una cittadina universitaria del Massachusetts e a un prestigioso college, celebre per le sue facoltà umanistiche. Il secondo olocausto americano vide quasi 30 milioni di africani rapiti e venduti come schiavi. Circa la metà morì durante la traversata atlantica. Eppure, nel 2001 la delegazione statunitense ebbe ancora il coraggio di uscire dalla Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban rifiutandosi di riconoscere che la schiavitù e la tratta degli schiavi fossero dei crimini. La schiavitù – era questa la tesi da loro sostenuta – all'epoca era legale. Gli Stati Uniti hanno altresì rifiutato di ammettere che i bombardamenti di Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, Dresda e Amburgo – in cui morirono centinaia di migliaia di civili – fossero dei crimini; di genocidi ovviamente non si parlava neppure. (Gli americani in questo caso sostenevano che il governo non intendeva colpire la popolazione civile. È stata la prima occasione in cui ha cominciato a svilupparsi il concetto dei «danni collaterali».) Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, il governo statunitense è intervenuto apertamente con spedizioni militari più di 400 volte in 100 paesi, e più di 6000 volte in segreto. Tra questi casi sono compresi l'invasione del Vietnam e lo sterminio, con ottime intenzioni, senza dubbio, di 3 milioni di vietnamiti (all'incirca un decimo della popolazione). Pagina 96 Forse l'aspetto più orrendo del «gioco dei genocidi» è che vengano classificati e messi in ordine secondo un ranking, come i tennisti del circuito professionistico internazionale. Le vittime sono suddivise in meritevoli e indegne. Prendiamo per esempio il genocidio di gran lunga più conosciuto, documentato e condannato: la Shoah, che è costata la vita a 6 milioni di ebrei. (Meno pubblicizzato da libri, film e documenti riguardanti l'Olocausto è il fatto che i nazisti abbiano sterminato anche migliaia di zingari, comunisti e omosessuali, oltre a 3.300.000 prigionieri di guerra russi, dei quali non tutti erano ebrei.) Il genocidio degli ebrei è stato accettato a livello universale come l'episodio più atroce della storia del XX secolo. A fronte di questo, alcuni storici definiscono la strage degli armeni il «genocidio dimenticato», e nel tentativo di ricordarlo al mondo lo chiamano «il primo genocidio del XX secolo». Peter Balakian, uno degli studiosi più attenti del genocidio degli armeni, autore di The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America's Response, sostiene che «il genocidio armeno è un punto di svolta. Fu un evento senza precedenti che cambiò il corso della storia. Diede inizio all'era del genocidio, che è – dobbiamo ammetterlo – ciò che è stato il XX secolo.» Il professore qui si sbaglia. L'«era del genocidio» era iniziata molto prima. Il popolo herero, per esempio, venne spazzato via dai tedeschi nell'Africa del Sud-Ovest solo pochi anni dopo l'inizio del Novecento. Nell'ottobre del 1904 íl generale Adolf Lebrecht von Trotha ordinò che gli herero venissero sterminati. Furono cacciati nel deserto e privati di cibo e acqua, in modo da annientarli. Nel frattempo, in altre parti del continente africano, il genocidio procedeva rapido. Francesi, inglesi, belgi: si davano tutti un gran daffare. Re Leopoldo del Belgio era nel pieno del suo «esperimento di espansione commerciale» in Congo, a caccia di schiavi, gomma e avorio. Costo di tale esperimento: 10 milioni di vite umane. Pagina 159 Glossario Adivasi: Letteralmente «abitanti originari», è il termine con cui si indicano i popoli appartenenti alle tribù indigene dell'India. Babri Masjid: Il 6 dicembre 1992, grandi folle violente di fondamentalisti indù si radunarono nella città di Ayodhya e demolirono la Babri Masjid, antica moschea. Fu il culmine di una campagna nazionale di «risveglio dell'orgoglio indù». La sostituzione della moschea con un grande tempio induista (il Ram Mandir) è in fase di progettazione. Bajrang Dal: Organizzazione militante del fondamentalismo indù, che prende nome dal dio Hanuman. Alleato con il Bharatiya Janata Party (BJP) e il Vishwa Hindu Parishad (VHP), il Bajrang Dal fu uno dei principali promotori della distruzione della Babri Masjid di Ayodhya nel 1992. Bharatiya Janata Party (BJP): Partito della destra nazionalista indù (letteralmente «Partito del popolo indiano»). Bhooka: Affamato. Chinar: Platano orientale. Grande albero a foglie caduche, assai diffuso nella valle del Kashmir e fondamentale per l'immaginario e la cultura della regione. «Confronto» di Ansal Plaza: Nel novembre del 2002 «specialisti del confronto» della polizia di Delhi, in incognito, uccisero due presunti terroristi del Lashkar-e-Taiba. Un medico, testimone dell'aggressione, disse che le vittime erano disarmate, e nel rapporto ufficiale sull'accaduto furono subito evidenti varie incongruenze. Dalit: Coloro che sono oppressi, ovvero «gli schiacciati». Termine più comunemente accettato per indicare la casta indiana un tempo definita degli «intoccabili». Hartal: Sciopero generale, forma di protesta diffusasi all'epoca della lotta di liberazione dell'India. Hindutva: Ideologia che mira al rafforzamento dell'«identità indù» e alla creazione di uno stato indù. È sostenuta dall'RSS e dal BJP, dallo Shiv Sena e da altri partiti settaristi. Hurriyat: Formazione politica kashmira fondata nel 1993, che riunisce 26 associazioni socio-politiche e religiose con lo scopo di raggiungere l'autodeterminazione. Il suo nome significa «libertà» in urdu. ISI: Inter-Services Intelligence, i servizi segreti pakistani. Lafanga: Piccolo malvivente, vagabondo. Lakh: Unità di misura indiana corrispondente a 100.000. Lal Chowk: Letteralmente «piazza Rossa». La principale piazza pubblica della città di Srinagar nella valle del Kashmir. Mohalla: Quartiere. Nanga: Nudo. Naxaliti, naxalismo: Movimento maoista che prende il nome dalla rivolta di una sezione del Partito Comunista Indiano (Marxista), il CPI(M), avvenuta nel 1967 a Naxalbari, nel Bengala occidentale. Pandit: Studioso o insegnante indù. Parsi: Appartenenti alla comunità zoroastriana dell'India. POTA: Prevention of Terrorism Act, legge per la prevenzione del terrorismo. Approvata dal parlamento indiano nel 2002, la legge fu annullata nel 2004 dal governo della United Progressive Alliance (guidata dal Partito del Congresso) perché giudicata ingiusta, usata in modo distorto e controproducente. È stata però sostituita di recente da una legislazione sul terrorismo ancor più restrittiva, sotto forma di emendamenti al già severo Unlawful Activities Prevention Act. Gli emendamenti sono stati presentati in parlamento il 15 dicembre 2008 e approvati il giorno seguente, praticamente senza alcun dibattito. Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS): Associazione culturale della destra indù, caratterizzata da una dichiarata posizione antislamica e dall'ideologia nazionalista dell'Hindutva. L'RSS fornisce l'impianto ideologico al BJP. (Il nome significa: «Gruppo nazionale di autoaiuto».) Sangh Parivar: Termite usato per indicare una serie di organizzazioni fondamentaliste indù di destra, strettamente legate fra loro, tra cui Bajrang Dal, BJP, RSS e VHP. Letteralmente significa «gruppo di famiglia». Shiv Sena: Partito sciovinista della destra indù a carattere regionale, concentrato nello stato del Maharashtra. Vishwa Hindu Parishad (VHP): Letteralmente «Consiglio mondiale indù», autonominatosi guida della comunità indù e componente del Sangh Parivar.
|
||
| top |